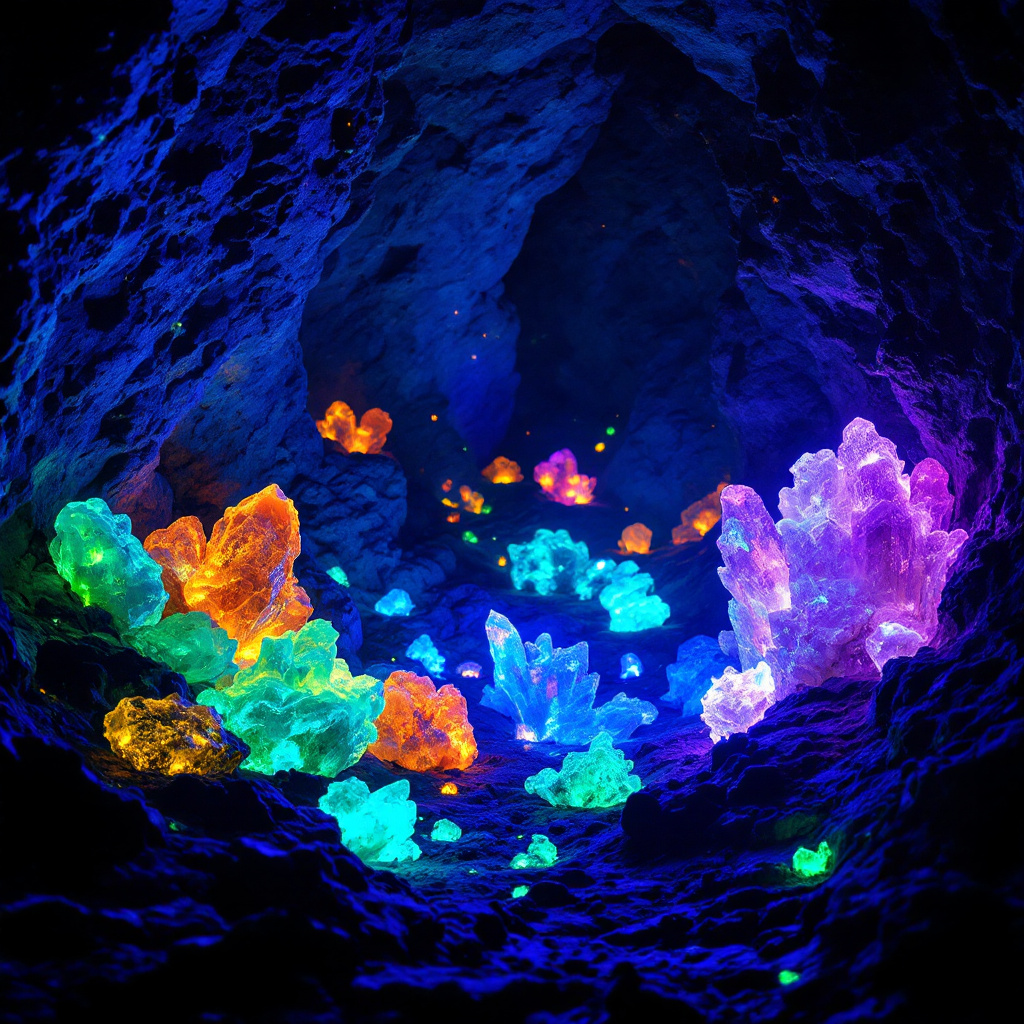Immagina di osservare l’universo come un’immensa ragnatela cosmica: filamenti luminosi di galassie e ammassi si intrecciano nel buio, separati da enormi cavità quasi deserte. Una di queste è così vasta e solitaria da essersi guadagnata un nome che evoca soggezione: il Grande Nulla. Conosciuto dagli scienziati come Vuoto di Boote, dalla costellazione in cui si trova, è una gigantesca regione sferica di spazio con un diametro di circa 330 milioni di anni luce. Per darti un’idea, se potessimo viaggiare alla velocità della luce, impiegheremmo 330 milioni di anni per attraversarlo.
Cosa lo rende così incredibile? Secondo i modelli cosmologici, in un volume di spazio così enorme dovremmo trovare migliaia e migliaia di galassie. Invece, nel Vuoto di Boote ne sono state scoperte appena una sessantina. È come esplorare un oceano grande quanto il Nord America e trovarci solo poche piccole isole. La discrepanza è così sconvolgente che, quando fu scoperto nei primi anni ’80 dall’astronomo Robert Kirshner e il suo team, mise in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere sulla struttura a grande scala dell’universo.
Ma cosa significa davvero “vuoto“? Non è un buco nero, né il nulla assoluto. Anche queste regioni contengono materia: gas incredibilmente rarefatto, qualche galassia solitaria e, soprattutto, materia oscura, la componente invisibile che governa la struttura del cosmo. Semplicemente, la densità di materia è drasticamente inferiore alla media. Per capire come possa formarsi un simile deserto, dobbiamo riavvolgere il nastro del tempo fino all’alba dell’universo.
Poco dopo il Big Bang, l’universo era una zuppa quasi uniforme, con minuscole fluttuazioni di densità. Nei miliardi di anni successivi, la gravità ha iniziato a fare il suo lavoro: le zone leggermente più dense hanno agito come calamite cosmiche, attirando materia e formando i filamenti e gli ammassi della ragnatela cosmica. Di conseguenza, le aree inizialmente meno dense si sono svuotate sempre di più. Il Vuoto di Boote è un caso estremo di questo processo: si pensa che sia il risultato della fusione di vuoti più piccoli, che crescendo si sono uniti per formare un “supervuoto“. Le simulazioni al computer confermano che, sebbene rari, eventi del genere sono possibili e non contraddicono le nostre teorie.
Ma perché questo vuoto ci affascina così tanto? Perché è una lente d’ingrandimento su alcune delle più grandi domande della cosmologia:
La sua stessa esistenza ci aiuta a calibrare i nostri modelli sull’universo primordiale. Inoltre, le poche galassie al suo interno sono preziose: essendo isolate, crescono in modo diverso, spesso più piccole e meno complesse, offrendoci un laboratorio naturale per studiare l’evoluzione galattica senza “interferenze” esterne. Infine, lo studio dei supervuoti è legato all’energia oscura, la forza misteriosa che sta accelerando l’espansione dell’universo, rendendo questi deserti cosmici ancora più isolati.
C’è persino un modo per “sentire” la sua presenza: i vuoti lasciano una debolissima impronta fredda sulla radiazione cosmica di fondo, la luce fossile del Big Bang. Studiando queste impronte, possiamo mappare la distribuzione della materia e dell’energia nel cosmo.
Il Grande Nulla non è un’anomalia che distrugge le nostre teorie, ma una straordinaria eccezione che le mette alla prova, definendone i limiti. È la prova che il nostro universo non è affatto monotono, ma un grandioso mosaico cosmico di pieni e di vuoti, di caos e di quiete. Forse, la sua lezione più profonda è proprio questa: anche il vuoto ha una storia da raccontare. Parla della forza instancabile della gravità, del flusso della materia attraverso le ere e di come, da differenze infinitesimali, possano nascere paesaggi di una vastità sconcertante. Nel silenzio del Vuoto di Boote, l’universo ci ricorda che l’assenza può essere potente ed eloquente quanto la presenza.
Potrebbe interessarti: