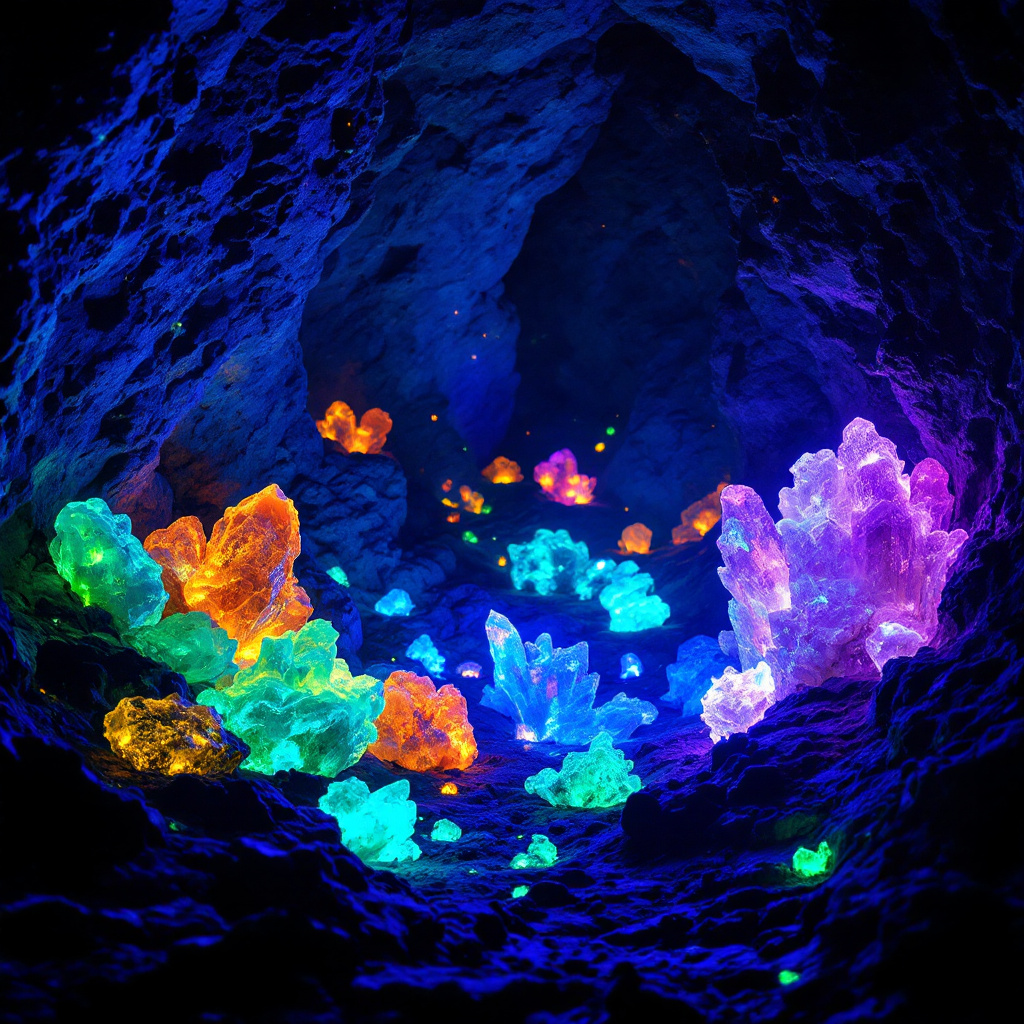Immagina di svegliarti in pieno giugno e vedere la neve cadere dalla finestra. Immagina raccolti che marciscono sotto piogge infinite, gelate improvvise a fine agosto e tramonti così rossi da sembrare incendi nel cielo. Non è un racconto fantastico, ma ciò che accadde davvero nel 1816, un anno passato alla storia come l’anno senza estate. E tutto cominciò dall’altra parte del mondo, su un’isola dell’Indonesia, con un vulcano di nome Tambora.
Nell’aprile del 1815, il Tambora eruttò con una violenza devastante, ancora oggi considerata la più grande eruzione mai registrata in epoca storica. Il boato fu udito a migliaia di chilometri di distanza. Il monte espulse una quantità enorme di magma e ceneri, tanto che la sua cima collassò, creando una caldera larga sei chilometri. Le isole circostanti furono sepolte e intere comunità spazzate via da colate piroclastiche e tsunami, causando decine di migliaia di vittime. Ma gli effetti più sconvolgenti dovevano ancora manifestarsi. La colonna eruttiva sparò gas fino alla stratosfera, a decine di chilometri d’altezza, innescando una reazione a catena che avrebbe cambiato il clima del pianeta.
Tra quei gas, l’anidride solforosa si trasformò in minuscole particelle di solfato. Queste particelle agirono come un gigantesco specchio, riflettendo parte della luce solare e impedendole di riscaldare la superficie terrestre. Il risultato fu un raffreddamento globale così intenso da alterare le stagioni per quasi due anni. Gli scienziati oggi lo chiamano “inverno vulcanico”. All’epoca, però, nessuno capiva perché il cielo fosse perennemente lattiginoso e le estati così gelide. La causa era un vulcano sconosciuto ai più, dall’altra parte del mondo.
Nel 1816, le conseguenze furono drammatiche. In Nord America nevicò a giugno, ricoprendo di bianco il New England e il Canada proprio quando i campi avrebbero dovuto fiorire. Le gelate fuori stagione distrussero i raccolti, tanto che molti americani ribattezzarono quell’anno “Eighteen Hundred and Froze to Death” (Milleottocento e si morì di gelo). In Europa, cieli grigi e piogge incessanti dominarono per settimane. I raccolti fallirono, il prezzo del cibo schizzò alle stelle e la fame scatenò rivolte e migrazioni. Persino l’arte ne fu influenzata: pittori come J.M.W. Turner immortalarono tramonti incandescenti, i cui colori erano resi innaturalmente vividi proprio da quelle particelle vulcaniche sospese nell’atmosfera.
Ma la curiosità più incredibile ci porta sulle rive del Lago di Ginevra. Nell’estate del 1816, un gruppo di amici illustri — il poeta Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, la sua futura moglie Mary Shelley e il medico John Polidori — si ritrovò bloccato alla Villa Diodati da un tempo cupo e tempestoso. Per sconfiggere la noia, Byron lanciò una sfida: ognuno avrebbe dovuto scrivere una storia del terrore. Fu in quel clima quasi surreale, tra discussioni sul galvanismo e la luce sinistra dei fulmini, che una giovanissima Mary Shelley concepì l’idea di uno scienziato che osa sfidare la natura per creare la vita. Da lì nacque il suo capolavoro: Frankenstein. L’oscurità e la tempesta nel romanzo non erano solo uno sfondo, ma il riflesso di un mondo reale, stravolto da un disastro naturale.
Non fu l’unica opera nata da quell’estate buia. John Polidori scrisse The Vampyre, un racconto che avrebbe gettato le basi per la figura del vampiro moderno, ben prima di Dracula. Anche la tecnologia ebbe uno sviluppo inaspettato. La carestia di avena, dovuta ai raccolti falliti, rese i cavalli troppo costosi da mantenere. Questo spinse l’inventore tedesco Karl Drais a perfezionare nel 1817 la sua “macchina da corsa”, l’antenata della bicicletta, un mezzo di trasporto che non aveva bisogno di cibo.
La cosa affascinante è come oggi possiamo ricostruire questa storia con precisione scientifica. Gli scienziati hanno trovato tracce inconfutabili del Tambora nei luoghi più remoti del pianeta: sottili strati di solfato vulcanico intrappolati nei ghiacci della Groenlandia e dell’Antartide, datati esattamente in quegli anni. Gli anelli degli alberi di tutto il mondo mostrano una crescita stentata, segno di stagioni freddissime. Questi indizi confermano ciò che i modelli climatici simulano: il nostro pianeta è un sistema profondamente interconnesso, dove un evento locale può avere ripercussioni globali.
La storia del Tambora ci ricorda la potenza sconvolgente della natura. Ma ci insegna anche che dai momenti più bui possono nascere idee rivoluzionarie. In un anno senza estate, mentre il Sole sembrava essersi spento, una giovane scrittrice diede vita a un mito immortale. Un vulcano che oscura il cielo può, inaspettatamente, illuminare l’immaginazione umana.
Potrebbe interessarti: