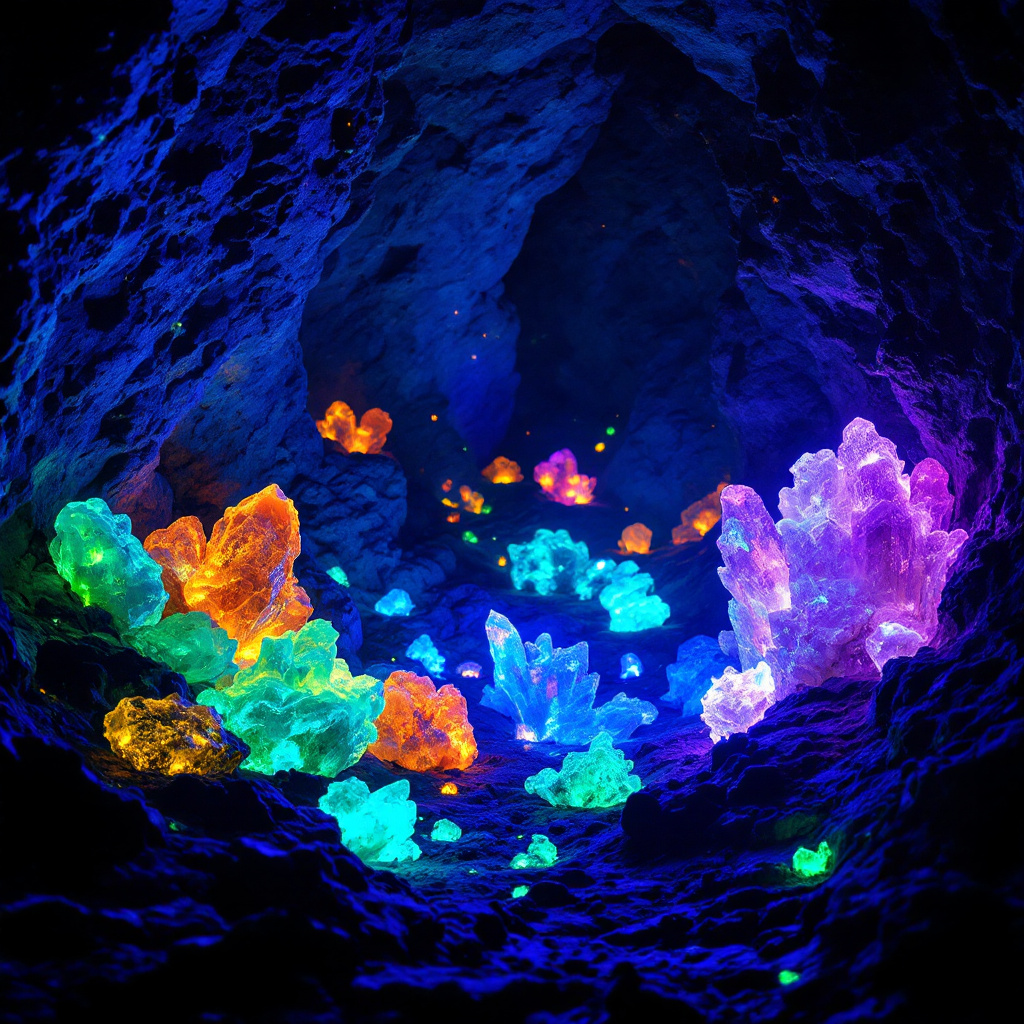Quando pensiamo a un temporale, l’immagine classica è quella del lampo che squarcia il cielo verso terra. Ma sopra le nuvole, a decine di chilometri di altezza, si scatena un’altra tempesta, silenziosa e quasi invisibile. È il regno dei TLE (Eventi Luminosi Transitori): lampi che non puntano al suolo, ma si proiettano verso lo spazio. Hanno nomi da fiaba, colori surreali e durano un soffio, tanto da sembrare miraggi. Eppure esistono, e rivelano un’atmosfera molto più elettrica e sorprendente di quanto immaginiamo.
Per decenni, i piloti di linea raccontavano di aver visto strani bagliori rossastri o bluastri sopra i cumulonembi in tempesta, ma spesso non venivano creduti. Solo alla fine degli anni Ottanta una telecamera a bassa luminosità riuscì a catturare il primo “sprite”, dando il via a un capitolo completamente nuovo della meteorologia. Da allora, satelliti, la Stazione Spaziale Internazionale, aerei di ricerca e un esercito di appassionati con fotocamere ultrasensibili hanno svelato un cielo capace di creare veri e propri fuochi d’artificio, visibili solo per pochi millesimi di secondo.
Ma cosa sono, esattamente, questi TLE? Sono scariche elettriche collegate ai fulmini tradizionali, che si sviluppano però negli strati più alti e rarefatti dell’atmosfera. La tempesta sottostante agisce come un generatore gigantesco. Quando un fulmine particolarmente potente colpisce il suolo, crea un enorme campo elettrico che si estende verso l’alto, eccitando l’aria fino alla mesosfera, tra 50 e 90 chilometri di quota. Il risultato sono figure luminose gigantesche ma debolissime, visibili solo nel buio più totale o con strumenti dedicati.
Gli sprite sono forse i più famosi. Appaiono come maestose colonne o “meduse” di luce rossa che si accendono all’improvviso sopra le tempeste più violente. Possono estendersi per decine di chilometri in altezza, con una base larga quanto una città. Il loro colore rosso deriva dall’azoto presente nell’aria rarefatta della mesosfera, che, colpito dall’energia, emette luce proprio in quella tonalità. A volte sembrano una foresta luminosa capovolta, altre volte meduse con tentacoli che scendono verso la nube. Durano pochi millisecondi e sono spesso preceduti da un “halo”, un debole alone luminoso.
Gli elfi sono ancora più rapidi e vasti. Si manifestano come un anello di luce rossastra in rapida espansione, una sorta di “ciambella” che in meno di un millisecondo può allargarsi fino a coprire un diametro di centinaia di chilometri. Il loro nome, in inglese (ELVES), è un acronimo che ne spiega l’origine: sono generati dall’impulso elettromagnetico di un fulmine potentissimo. È come se l’onda radio del fulmine colpisse la ionosfera, accendendola per un istante come un’enorme lampada al neon.
I getti blu (Blue Jets) sono diversi: non scendono dall’alto, ma partono dalla cima della nube temporalesca per salire verso lo spazio. Sono come lance di luce bluastra che si arrampicano per decine di chilometri nella stratosfera. Il loro colore blu intenso è dovuto a molecole di azoto eccitate a un’energia superiore. Esistono anche i “getti giganti”, molto più rari, che possono raggiungere la base della ionosfera, a quasi 90 chilometri di altezza, collegando direttamente la tempesta con il confine dello spazio.
Perché si formano? La spiegazione più semplice è che un fulmine molto potente, in particolare uno che trasferisce carica positiva dalla nube al suolo, lascia dietro di sé un forte squilibrio elettrico. Per un istante, questo genera un campo elettrico immenso che si propaga verso l’alto. Lì, dove l’aria è sottilissima, basta questa “spinta” per innescare la scarica e far nascere uno sprite o un elfo. I getti, invece, sembrano nascere quando una tempesta non riesce a scaricare la sua energia verso il basso e trova una via di fuga verso l’alto.
Questi fenomeni sono molto più comuni di quanto si creda. Quasi ogni grande sistema temporalesco ne produce, ma la maggior parte sfugge ai nostri occhi. Per vederli serve un orizzonte libero, grande distanza dalla tempesta e completa oscurità, oppure una prospettiva privilegiata come quella offerta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Proprio a bordo della ISS, l’esperimento ASIM ha registrato centinaia di eventi, confermando la ricchezza di questo spettacolo celeste.
Anche se non rappresentano un pericolo diretto, i TLE sono fondamentali per capire come la Terra “respira” elettricità. Ogni scarica trasferisce energia e modifica la chimica degli strati atmosferici, contribuendo al cosiddetto circuito elettrico globale che collega il suolo, le nuvole e la ionosfera. Quando osserviamo uno sprite, stiamo vedendo la Terra interagire con lo spazio vicino.
La scienza, di fronte a fenomeni così nuovi e spettacolari, si è concessa un po’ di fantasia, battezzando altre manifestazioni con nomi come “pixies” (folletti) e “gnomes” (gnomi), piccoli lampi sulla cima delle nubi, o “trolls” (troll), scie luminose che a volte seguono gli sprite. In fondo, i TLE ci ricordano che il cielo non finisce dove smette di piovere. Sopra ogni temporale c’è un ponte di energia che collega il nostro mondo allo spazio, un teatro fatto di fulmini capovolti e anelli di luce. Un mondo a lungo rimasto nascosto, che ci dimostra come anche nei fenomeni più familiari ci sia ancora tantissimo da scoprire.
Potrebbe interessarti: